VARESE
Ponti tra scienza e società
Intervista alla divulgatrice Roberta Villa
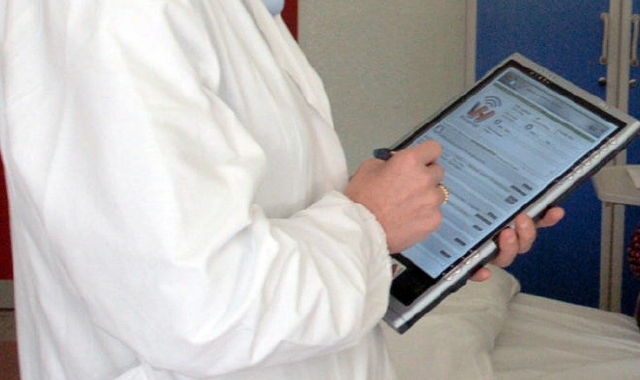
INforma Insubria è un progetto che nasce durante il corso di Psicologia e Tecnica della Comunicazione per la salute e il benessere all’interno della facoltà magistrale di Scienze e Tecniche della Comunicazione dell’Università Insubria e che, visto il crescente interesse, ha valicato i confini universitari per approdare sulle pagine di Prealpina.it. La rubrica è interamente curata dagli studenti che con il supporto dei loro docenti: Alberto Martina e Silvia Milone, trattano argomenti come la salute e il benessere, intervistano importanti personalità del territorio e forniscono qualche spunto su come praticare dello sport all’aria aperta. Una rubrica pensata dai giovani per comunicare in modo semplice con tutti.
Roberta Villa, giornalista laureata in medicina e chirurgia, in questa intervista ci parla di
comunicazione on e off line, e di come la divulgazione scientifica debba essere orientata a costruire dei legami tra scienza e società. In poche parole: rispetto e ascolto dell’utente, nonché responsabilità. Responsabilità di comunicare in modo chiaro e trasparente, vero e onesto. Elementi che di certo ritroviamo nel suo modo di essere online: semplice e confidenziale, caratterizzato da lunghe riflessioni che aiutano l’ascoltatore a costruirsi un opinione personale, facilitandone l’empowerment.
Le parole dell’esperta
Come è iniziata la sua carriera da giornalista scientifica?
«Il mio non è mai stato un percorso regolare. Mi sono iscritta a Medicina per l’aspetto umano e umanitario della disciplina, ma solo grazie alla collaborazione con Tempo Medico – una delle maggiori riviste per medici italiana – mi sono innamorata dell’attività di redazione. Un mondo molto diverso rispetto ad oggi: i tempi erano dilatati, i grafici dicevano che non avrebbero mai usato un computer e ho fatto in tempo a vedere i menabò tagliati a mano. Dal punto di vista professionale ho sempre avuto la necessità di reinventarmi. Ho iniziato a scrivere per un target più ampio tramite il Corriere della Sera, e con alcuni progetti europei – Tell me Project, Asset e Quest – ho cambiato totalmente il tipo di lavoro. Mi sono occupata di ricerca in ambito di comunicazione e divulgazione della scienza legata alle pandemie. Ho lavorato anche in ambito istituzionale con AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – e soprattutto sono entrata nel team di Dottoremaeveroche, un’iniziativa di FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri –. Nel mio fare divulgativo mi piace far riflettere, aiutare le persone a costruire un contesto intorno ad un certo tema».
Ha parlato di necessità di reinventarsi in un mondo che cambia: che differenze trova tra comunicazione e divulgazione scientifica legata a media tradizionali e nuovi media?
«La radio è un’ottima fonte di informazione scientifica: ha un’audience molto fidelizzata, e se si riesce a sintetizzare in tempi brevi dei concetti base, questi possono arrivare molto bene. La televisione, invece si lega spesso al tema della false balance: chiama ciarlatani solo per fare ascolto, quando invece dovrebbe dare più spazio a momenti di confronto in un clima rilassato. Lavorare per giornali tradizionali, cartacei, significa avere limiti di spazio ma maggior agio nel tempo. Quando lavoravo a Tempo Medico vi era una cura spasmodica ai dettagli, alla qualità e all’affidabilità. Con Internet il sistema informativo è andato incontro ad un’accelerazione dei tempi e al fenomeno della disintermediazione. In particolare, il giornalismo ha dovuto iniziare a rincorrere la notizia, a scapito – purtroppo – di tanti temi inerenti al fact checking. Su questo specifico aspetto, la pandemia da Covid-19 ha messo in luce la necessità di una re-intermediazione. Nessuna forma di censura: lasciare l’accesso a tutto a tutti, ma dare l’opportunità, a chi vuole, di avere un filtro di contesto, di qualità, di valutazione e cernita delle notizie. Ecco, questo è quello che io cerco di fare tramite i social, che al di là dei tanti aspetti negativi, restano uno strumento meraviglioso garantendo la bidirezionalità in ogni comunicazione. I social danno la possibilità di capire direttamente i bisogni informativi dei cittadini e quindi facilitano la costruzione di un rapporto di fiducia, che io sento davvero. Escludo che siano l’unica fonte di disinformazione, e la Pandemia lo sottolinea: tutti i mezzi di comunicazione sono stati legati a disinformazione, non solo i social media. I social media possono essere riempiti di buoni contenuti, come di cattivi contenuti, e lo stesso vale per i giornali, per la televisione, e per la radio».
Secondo lei quali sono le parole chiave in fatto di comunicazione e divulgazione scientifica?
«Fare divulgazione di qualità significa avere rigore scientifico, quindi adesione ai dati e alla solidità della ricerca che si riporta, trasparenza, chiarezza e relazione per non minare la fiducia del pubblico. Se dovessi scegliere una parola chiave che poi racchiude tutte le altre è responsabilità: quello che dice il divulgatore può influire sulla vita delle persone. Questi sono i miei obiettivi comunicativi:
espongo sempre un ragionamento, non nozioni calate dall’alto. Il ragionamento aiuta le persone a porsi delle domande, a sviluppare uno spirito critico che diventa importante a tutti i livelli».
Concludendo, che caratteristiche dovrebbe avere un buon comunicatore scientifico?
«Da un lato deve sentire la comunicazione scientifica come una missione, ma dall’altro non dimenticarsi che è un lavoro. Quindi riflettere su business model che siano sostenibili nel tempo. Quello di adesso è un mondo in divenire in cui costruire ponti tra scienza e società. L’elemento imprescindibile è il rispetto: se si vuole comunicare qualcosa a qualcuno bisogna sintonizzarsi su di lui e usare con estrema cautela l’aspetto emotivo. In un mondo dove la scienza è sempre più specializzata abbiamo bisogno di flessibilità, apertura mentale e voglia di creare legami tra discipline diverse.»
© Riproduzione Riservata


